Qualche tempo fa, passando davanti al Moleskin Cafè in
Corso Garibaldi a Milano (come succede oggi, e forse ancor di più, davanti a
qualunque altro locale “cool”), si potevano vedere moltitudini di giovani che
s’adoperavano sulla tastiera dei loro computer, tutti della mela morsicata. In
questa semplice immagine (che appare assolutamente inoffensiva) è racchiusa
tutta la potenza del SIMBOLICO nell’ambito del consumo nella società
contemporanea. C’è da chiedersi se tutti quei trentenni sono dei progettisti
industriali o dei grafici freelance. Immaginiamo di no altrimenti non
starebbero lì ma da qualche altra parte a lavorare. Probabilmente stavano
“navigando” in rete a cazzeggiare o utilizzando un normalissimo word processor
per redigere il proprio curriculum vitae (nel formato europeo, per carità!)
nella speranza d’andarci (ovviamente a lavorare).
E allora perché tutti avevano un computer Apple e
tutti erano seduti al Moleskin Cafè (et
similia) visto che quei computer costano il doppio degli altri e il caffè in
quel posto era più caro che negli altri bar? In questo caso non è una colpa
(ideologica) domandarci: qual è la merce? Il computer Apple e il caffè? No. Il
“prodotto computer Apple”, per quei giovani, aveva un valore d’uso inferiore
rispetto alle sue potenzialità intrinseche e lo stesso dicasi per il caffè
rispetto al prezzo. Insomma se si deve scrivere un curriculum basterebbe un
volgare computer Microsoft (molto più economico) e la stessa cosa dicasi se si
ha voglia di un caffè. Allora la merce “vera” è il simbolico che ricopre quei
prodotti. Insomma è la mela morsicata (logo) e il nome del bar o l’immagine che
esso ha (logo). Lo stesso vale per i prodotti della moda o del design (e qui la
cosa è ancora più evidente, anzi ne costituisce la ragion d’essere) dove si
vende e si “consuma” un’esperienza che diventa merce (status sociale e
riconoscimento). Il prezzo è soltanto l’elemento secondario. Per chi vale
questo processo di consumo? Solo per coloro che hanno i soldi e quindi se lo
possono permettere? No. Vale per tutti, anzi vale ancor di più per chi i soldi
non li ha perché viene considerato (ovviamente a torto) elemento di rivalsa
sociale (sono povero ma voglio sembrare diverso). Il simbolico d’una merce
costruisce, quindi, un immaginario che induce, soprattutto in chi è escluso da
un certo stato sociale, l’aspirazione a farne parte.
Ma non basta: nelle società con una massiccia
presenza di lavoro cognitivo le merci hanno perso la caratteristica della
materialità (un bullone, una lavatrice, etc…) a favore dell’immaterialità (una
stringa di software, l’articolo di un blog, il “cosa stai pensando” del profilo
Facebook, le foto su Instagram). A produrre queste nuove merci non sono i
talentuosi e meritevoli ingegneri californiani magari ben retribuiti, ma gli
utenti stessi, che attivano un processo di socializzazione del lavoro non
pagato. Si produce una disseminazione del lavoro, ovvero si continua a
lavorare e produrre ricchezza (non per noi), così ogni interazione che ha luogo
fuori dall’orario di lavoro, assume la forma di una donazione, non viene
contabilizzata come lavoro e quindi non può essere retribuita. Questa è la
nuova frontiera dello “sfruttamento”: la dilatazione spazio-temporale senza
limiti della propria prestazione. In questo scenario ogni operazione svolta a
titolo gratuito, ogni interazione sul web, generano un plusvalore assoluto
(totale). Il paradosso si compie se si pensa che i mobilitati, gli
utenti/lavoratori, oltre a mettere costantemente a disposizione ore di
connessione per rispondere a mail, post e messaggi, si fanno carico finanche
dei mezzi di produzione come computer, smartphone, energia elettrica, contratti
con gestori telefonici. In maniera implacabile il lavoro viene così
collettivizzato e diluito anche all’interno di ogni processo di
socializzazione, solo in apparenza scollegato alla giornata lavorativa,
sfruttando l’adesione volontaria (inconsapevole?) del singolo. Ma come e perché
si può essere sfruttati, dominati, eppur felici? Perché siamo esseri
desideranti, appassionati; quello che il Capitale fa nel lavoro, soprattutto
cognitivo, è un operazione di asservimento delle passioni ai fini della propria
riproduzione, allineando il desiderio di chi viene “ingaggiato” a quello del
“desiderio-padrone”. Il Tiranno vuole essere amato!
Ma nella società contemporanea il simbolico e lo
sfruttamento vanno sempre a braccetto con la ritualità. Il RITO nella
modernità si può definire come un processo ATTIVO di riconoscimento d’una
comunità basato sulla liturgia e sulla ripetizione nel tempo (entrambi questi
aspetti sono fondamentali). Attivo perché, nella sua concretezza
comportamentale, CREA (cioè non rispecchia un fenomeno sociale spontaneo ma
costituisce, determina) il senso di quella comunità. Inoltre esso richiede che
sia una moltitudine che lo espleti e non il singolo, che costruisca una sua
liturgia, vale a dire una modalità di espletamento e infine che sia ripetitivo
nel tempo. E questo vale per tutti i “rituali sociali” in tutti i tipi società,
da quelle più antiche a quelle contemporanee. Un singolo individuo, per
esempio, che va a bere un bicchiere di vino una volta ogni tanto con gli amici
prima di cena è l’esempio di un bisogno sociale ma una moltitudine (comunità),
grande o piccola che sia, che spesso (ripetitività) riempie i tavolini dei
locali per fare “l’happy hour” (liturgia) è un rito e quindi diventa uno
strumento di riconoscimento e di identificazione. Esso NON è l’espressione del
bisogno sociale collettivo di bere un bicchiere di vino bensì l’opposto, ovvero
determina il bisogno del bicchiere di vino in quanto così ti riconosci e fai parte
d’una comunità. Insomma se non ci sei non sei, se non lo fai non esisti. Ecco
allora un piccolo esempio attraverso cui si esplica la microfisica del potere (rileggere
Foucault). Vale a dire un comportamento sociale ritualizzato costruisce un
meccanismo di controllo sociale (controllo del conflitto) diventando, insieme
ad altri fattori (vedi la spinta al consumo attraverso il simbolico), cultura
egemone.
Per conoscere meglio i meccanismi di
dominio e controllo della società contemporanea (soprattutto nell’ambito del
digitale) consigliamo la lettura de LA
VALLE OSCURA di Anna Wiener pubblicato da Adelphi: una cronaca angosciante
del lavoro nella Silicon Valley.
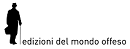

Commenti
Posta un commento