“Merito” è un
parola bastarda. È viscida, infida, bugiarda. Eppure si presenta con una faccia
per bene, col suo nasino all’insù, pettinata, profumata, fresca e fragrante
come se fosse appena uscita dalla doccia. Sono in molti, troppi, a farne una
bandiera illudendosi, poverini, che sia la ricetta miracolosa per combattere il
nepotismo e il clientelismo. Ma è esattamente il contrario: dietro al suo abuso
si sviluppa l’intrallazzo più spudorato. Ma è anche una parola di grande
potenzialità che apre orizzonti inaspettati su strade oggi poco battute,
infatti avviandoci alla sua “critica” si ha l’opportunità di smascherare i
meccanismi di dominio ideologici della società capitalista. Ma andiamo con
ordine.
Innanzi tutto il
“merito” è una partita truccata, una gara (una gara sì, perché sottende un’idea
di competizione) dove i blocchi di partenza non sono sulla stessa linea, al
contrario di quello che ci fanno credere (tutti abbiamo le stesse possibilità).
Non tutti partiamo dalla stessa situazione. Le differenze sociali (dicasi le
differenze di classe) determinano sempre il punto di partenza. E c’è chi sta
dietro e chi sta davanti. Il figlio di una famiglia borghese, con i genitori
laureati, che vive in un ambiente sia economico (dove si ha la possibilità di
studiare, di pagarsi la formazione, di vivere in un contesto imprenditoriale o
professionale) che culturale (con l’abitudine alla lettura, al teatro, al
cinema, a viaggiare) è molto avvantaggiato rispetto al figlio di un proletario
i cui genitori svolgono un lavoro salariato e hanno un livello d’istruzione
medio/basso. Questa è una banalità (oltre che una verità) ma si fa fatica a
renderla un’acquisizione comune. E già qui la parola “merito” dimostra la sua
natura menzognera. Al massimo, se proprio vogliamo inoltrarci in un esercizio
assurdo, si potrebbe misurare il merito tra pari ma mai tra dispari! Declinata,
la parola “merito, nell’ambito dell’istruzione ci fa dire, allora, che
l’istruzione è di classe. Il nuovo Governo di destra, cambiando il nome al
ministero specifico ha espresso il proprio manifesto ideologico. L’esperienza
della scuola di Barbiana e di Don Milani non ha insegnato niente. Eppure di
quell’esperienza si sono nutriti il ’68 e i movimenti studenteschi di quegli
anni, oltre che semplicemente le persone più aperte e informate. Agli
insegnanti di oggi, ahi noi così attenti al merito e alla competizione come
strumento didattico, si dovrebbe rendere obbligatoria la lettura di “Lettera a
una professoressa” invece di cambiare il nome al ministero da cui dipendono.
In secondo
luogo la parola “merito” ci porta a riflettere su un'altra parola, anch’essa
bugiarda, forse più della prima: individuo. Il merito si misura solo sull’individuo.
Dicono i soloni del neoliberismo. Ma chi o cos’è l’individuo? “…Nessuno si crea da solo. Tutti siamo come
ci hanno plasmato le nostre relazioni, le nostre reti, i nostri rapporti”.
Insomma l’individuo preso nella sua singolarità è un concetto astratto che non
ha alcun senso. Provate a immaginare un essere vivente fuori dall’ambiente in
cui vive e senza relazioni con nessun altro essere. È impossibile anche solo
pensarlo, è soltanto una falsa idea. La “società degli individui” tanto cara ai
liberisti è pura invenzione, è un antinomia. Sono le relazioni tra individui
che costituiscono e definiscono la società trasformandosi in miti, riti,
cultura, abitudini e leggi. E anche, per assurdo, se si volesse prendere in
considerazione il concetto di “merito” questo non è attribuibile all’individuo
perché il processo di conoscenza, di acquisizione di competenze e quant’altro,
è sostanzialmente un processo collettivo, collaborativo, che scaturisce dalla
società (e dal periodo storico in cui essa è). Il genio non esiste, è semplicemente
una menzogna.
In terzo luogo
la parola “merito” legata all’individuo ci porta inevitabilmente ad analizzarne
un’altra: competizione. Vince chi merita, si dice. Se tutti fossero uguali non
ci sarebbe nessuno che “merita” di più. Qualcuno merita rispetto a qualcun altro che
non merita. Questa è “una visione del
mondo che giustifica e promuove la competizione universale – una versione
totalizzante del darwinismo sociale – come soluzione naturale di tutti i
problemi: il sistema ottimale, si sostiene, di allocare le risorse – anche
quelle cosiddette umane – e promuovere il benessere di tutti. Il darwinismo
sociale legittima le diseguaglianze responsabilizzando o colpevolizzando gli
individui per la loro condizione: ciascuno è quello che è (povero o ricco,
potente o emarginato) perché se l’è meritato, se l’è voluto, se l’è andata a
cercare.” Questo passo di Guido
Viale (contenuto nel libro Slessico Familiare) illustra molto bene il
retropensiero che si nasconde dietro la cultura del “merito”. Retropensiero,
per altro, falso in quanto ogni progresso di coscienza e conoscenza è sempre un
processo collaborativo e non individuale ma che viene sbandierato dal pensiero
dominante al fine di mantenere lo status quo.
Per ultimo, ed
è questo l’aspetto più importante, non si può non porsi la domanda: chi
giudica? E già, perché come si fa a dire che qualcuno o qualcosa merita?
Occorre che ci sia un criterio di riferimento o di giudizio. Ma questo criterio
è oggettivo? Oppure è sempre soggettivo? Ma il “merito” “…viene stabilito da qualcuno che sta al di sopra in una struttura
gerarchica: una posizione che gli è stata attribuita da qualcun altro, che a
sua volta stava al di sopra di lui; e che occupava quella posizione per un
merito riconosciutogli da uno ancora superiore. E così via fino ai vertici di
chi non è stato giudicato meritevole da nessun altro perché al di sopra di lui
non c’è nessuno e a nessuno deve rispondere. Una volta costui era il sovrano
che rispondeva solo a Dio. Adesso al vertice della piramide stanno i poteri dell’alta
finanza che risponde solo a se stessa e ai propri interessi” (sempre Guido
Viale in Slessico Familiare). Appare chiaro, quindi, che i criteri per valutare
il “merito” sono esclusivamente soggettivi (di un uomo o una classe) e quindi
per niente universali. Dipendono da chi giudica. In una società capitalistica,
ma anche in qualsiasi altro modello di società compreso quello socialista, è il
pensiero egemone che stabilisce i criteri attraverso i quali si giudica “il
merito”. In questo modello di società capitalista il successo e l’accumulo
della ricchezza sono meritori… ma chi l’ha detto? In altri modelli di società non
lo sono, anzi sono una colpa. E quindi? Non se ne esce: in ogni società
(qualunque essa sia) è il pensiero della classe dominante (il pensiero egemone)
che definisce i criteri del merito e questo aspetto va riconosciuto apertamente.
Insomma i criteri di giudizio non vanno mai contrabbandati come oggettivi ma
sono sostanzialmente ideologici.
Al fine… che
dire? “Criticare” il concetto di “merito” ci porta a capire i meccanismi
ideologici profondi della società capitalistica e ci dimostra come questo sia una
menzogna figliata dal pensiero egemone con l’unico obiettivo di mantenere
immutato il potere della classe dominante. Di certo In una società di pari dove
vigesse il principio “ognuno secondo le
proprie capacità” non avrebbe più senso il concetto di “merito”. Ma prima
occorrerebbe liberarsi da ogni bisogno (“a
ognuno secondo i propri bisogni”).
Consigli di
lettura:
Lettera a una professoressa della
scuola di Barbiana – Libreria Editrice Fiorentina
Slessico familiare di Guido Viale –
Interno 4 edizioni
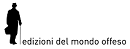

Commenti
Posta un commento